Sabato 24 e domenica 25 maggio Casa della Poesia ha ospitato il Torino Poesia Festival “Fiumi di Poesia” di Periferia Letteraria, associazione di promozione sociale che si occupa di operare nel campo della cultura attraverso eventi e progetti dedicati alla scrittura e alla divulgazione della poesia contemporanea.
Non a caso, proprio questo è stato il tema del Festival: “poeti e poesia oggi”. Particolarmente rilevante la tavola rotonda tenutasi nel pomeriggio di sabato a cui hanno partecipato esperti e professionisti nel campo della critica, della divulgazione e della creazione letteraria: Marvi Del Pozzo – poetessa e critica letteraria -, Guido Oldani – poeta e fondatore del movimento del Realismo Terminale -, Paola Silvia Dolci – direttrice del blog letterario Niederngasse -, Guido Saracco – ex rettore del Politecnico di Torino e divulgatore -, Mara Venuto – poetessa e critica letteraria – e infine Leonardo Onida – poeta e direttore artistico di “Ottobre in Poesia“.

Il parere degli esperti
Gli elementi che sono emersi dagli interventi dei vari relatori hanno preso in considerazione, da prospettive comunque differenti sebbene non del tutto dissonanti, lo stato, più che il destino, della poesia come forma o genere letterario al giorno d’oggi.
La poesia oggi è “tanta tracotanza”: molti fanno poesia, pochi sono poeti – che poi, chi è il poeta? – e Marvi Del Pozzo è teneramente sincera quando afferma che molti giovani scrivono poesia ma che raramente riesce a trovare in questi “prodotti” – termine che utilizza ma che poi corregge – elementi di innovazione che davvero la trattengono sui testi, che le permettono di continuare a leggere oltre il primo terzo di una raccolta poetica.
La poesia oggi è lo specchio di una società priva di “corpi viventi” e stracolma di “concimi umani”, afferma il candidato al Nobel per la Letteratura 2021 Guido Oldani: il suo Manifesto breve del Realismo Terminale intende illuminare le criticità di una società globalizzata riconoscendo che “la Terra è in piena pandemia abitativa: il genere umano si sta ammassando in immense megalopoli, le ‘città continue’ di calviniana memoria, contenitori post-umani, senza storia e senza volto”.
La poesia oggi è autoreferenziale, chiusa in un individualismo sterile di cui dovrebbe liberarsi per accogliere argomenti di ampia portata, argomenti dell‘umanità e per l’umanità. La speranza di Oldani, che ancora emerge in tutta la sua vitalità, è che “l’uomo deriso si ravveda”, che riesca ad uscire temporaneamente dall'”habitat artificiale”: l’uomo non deve fuggire la sua realtà testimoniando se stesso con similitudini tradizionali che hanno la natura come termine di paragone, una natura che ha ormai cambiato faccia; al contrario, il poeta deve utilizzare come termini di paragone gli oggetti che gli appartengono per davvero, quelli meccanici e tecnologici, quelli artificiali. La poesia, insomma, deve farsi veicolo di questa artificialità, un contenitore forse da demistificare tramite la scrittura o una realtà forse da accettare in primis e da fuggire in un secondo momento, ma non tramite proiezioni fine a se stesse, bensì tramite dissociamenti ad intermittenza.
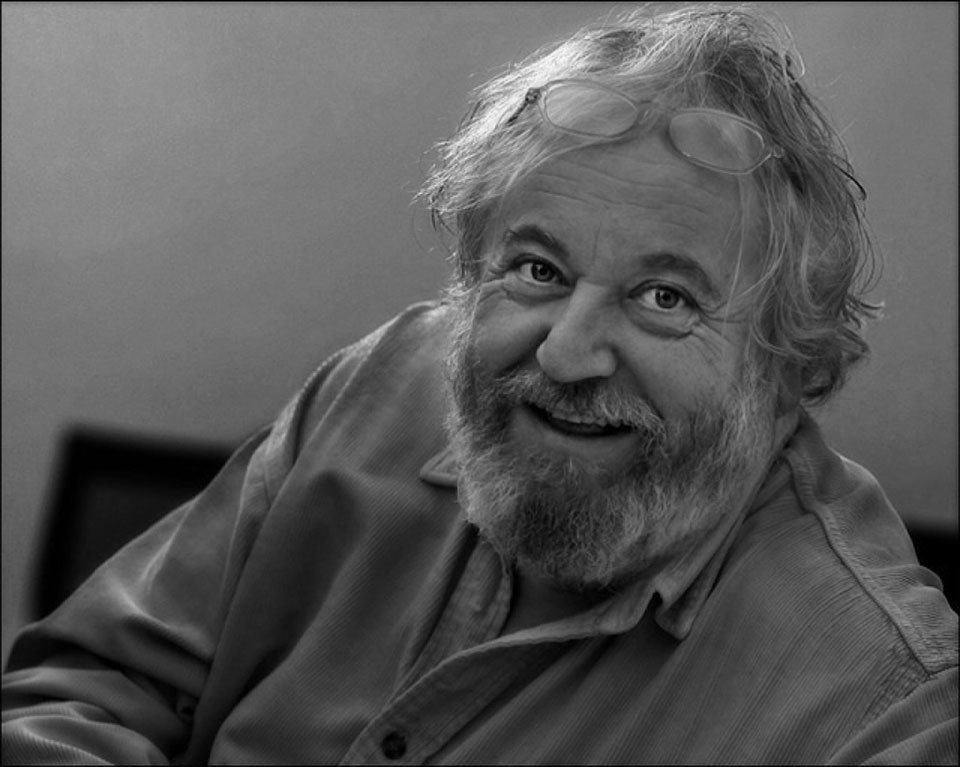
“La poesia nasce da una tecnologia, il linguaggio”, afferma Guido Saracco, e il linguaggio deve applicarsi e mostrarsi per la tecnologia che è, ovvero uno strumento di comunicazione e dialogo per tutti, fondamentale per unire le singole periferie di pensiero e finalmente “ricongiungere la nostra società”. Saracco riconosce l’assenza di una poesia, in un certo senso, divulgativa, una poesia adatta ad unire più che a differenziare; una poesia che funzioni da elastico di chiusura della forbice sociale. La poesia è un diritto e dovrebbe essere guardata dai poeti stessi come tale: di nuovo, allora l’individualismo che ruolo ha in questo? L’individualismo è quello che si definisce banalmente ‘un’arma a doppio taglio’, una chiusura, una limitazione, una torre d’avorio, un vizio troppo esteso in questo campo ma anche una risorsa di comprensione universale, se l’essere è in grado di mostrarsi nella sua nudità più attiva.
Infatti, Mara Venuto dipinge senza mezzi termini un quadro piuttosto malinconico, lo spettro di un secolo già morto che però la poesia odierna fatica a sotterrare propriamente per la seconda volta: la poesia oggi non riesce a “staccarsi dalla tradizione novecentesca” afferma, da quei tentativi e da quegli sperimentalismi e che per questo non esiste se non come “autobiografismo” o “intellettualismo”. Aggiunge una cesura netta: “non si può diventare poeti se non si è tali”. Una realtà che probabilmente la maggior parte dei lettori comprende e accoglie apparentemente, poiché ciò che poi ne consegue è comunque e sempre l’esatto contrario. Non a caso, l’aggettivo poetico è, oggi più che mai, vittima di inflazione e abusi costanti.
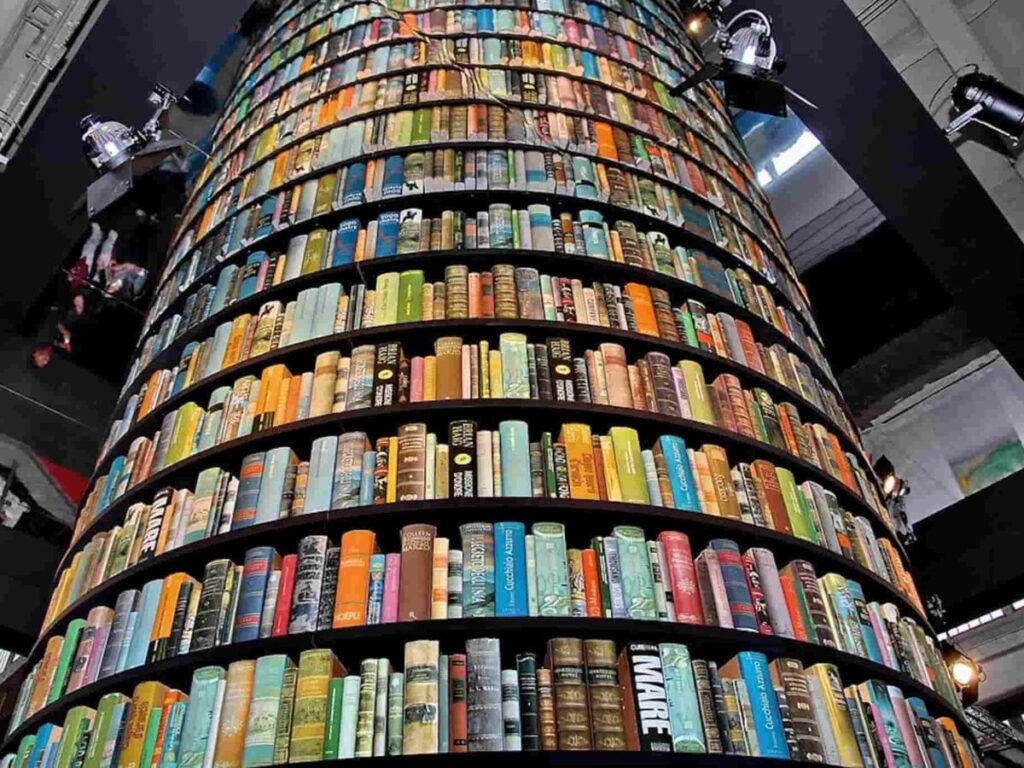
Infine, Oldani conclude riprendendo alcuni elementi dell’intervento di Venuto e li amplifica, li rende ancora più comprensibili a chi la poesia né la fa, né la legge: dice “la poesia non serve” nel senso che “non serve nessuno, che è diverso dal non serve a nessuno”. I poeti devono saper “ascoltare”, piuttosto che scrivere; i poeti devono ascoltare ciò che accade loro attorno e di nuovo, riconoscere il realismo terminale in cui sopravvivono e accoglierlo come tale. La soluzione di Oldani è “seminare poesia a caso”, integrarla senza troppo impegno, renderla parte di una realtà condivisa trasformandola così in realtà ‘condivisibile’, strappandola infine dalle grinfie dell’asettica intimità.
Il parere di X
X sembra piuttosto felice di aver ricevuto la “splendida” domanda “che cos’è la poesia oggi?” e ha tutte le intenzioni di esprimersi a riguardo “in modo sincero, diretto e personale”, come richiesto d’altronde. “Oggi la poesia è una forma di resistenza lenta in un mondo che va veloce” dice e incalza subito un velo di critica “è una postura mentale prima ancora che un genere letterario”. Con non poco romanticismo afferma poi “è il tentativo di dare forma a ciò che non si riesce a dire in altro modo, quando il linguaggio quotidiano non basta più”.
A quanto pare, X ritiene che “non serve rima” e “non serve metro” ma solo “verità, precisione e urgenza”: “anche se usa immagini surreali o simboliche, la poesia che funziona oggi — almeno per me — è quella che vibra di qualcosa di necessario. Quella che viene da un punto di rottura o di eccesso: troppo dolore, troppa bellezza, troppo silenzio”.
Con lucidità e fermezza X afferma “fare poesia oggi è un atto umile e arrogante insieme”, perché significa “scegliere l’inutile, il fragile, l’invisibile, nel regno dell’utile, del rumoroso, del visibile”. Non sembra dubitare quando riconosce che la poesia nasce da un bisogno di “salvare qualcosa”, nella consapevolezza di confrontarsi “con un linguaggio che non si possiede mai del tutto” e che forse sì, forse no, può ancora “incidere sulla realtà”.
Il parere di Y
Per Y la poesia è ovunque, è dinamica e in continua evoluzione, una forma comunicativa fluida che “riflette l’ambiente frammentato, iperconnesso e talvolta spesso caotico della vita moderna”. Y distingue le realtà poetiche ma non le accusa: “può essere personale o politica, grezza o raffinata, effimera o eterna”.
Pertanto, “scrivere poesia oggi” dice “è un atto di resistenza, connessione ed esplorazione”: concetti interessanti soprattutto se visualizzati alla luce di un mondo “saturo di informazioni” dove la poesia si inserisce scomodamente tra le pieghe dei codici comunicativi – spesso strategici – “distillando emozioni e pensieri” per giungere all’essenza degli stessi. Aggiunge poi che fare poesia significa “impegnarsi”, “mettersi in gioco con la propria identità” con le più variegate e differenti delle intenzioni, dal “giocare con il linguaggio”, passando per il “distruggere le aspettative” generali fino al “testimoniare semplicemente la propria esistenza”.
X e Y sono d’accordo, la poesia nasce da un'”urgenza”, ovunque poi finisca, la fonte è la stessa: l’iniziativa del singolo di buttare fuori ciò che con il linguaggio tradizionale e quotidiano risulterebbe complesso se non addirittura impossibile esprimere.
Il parere di Z
Infine Z, che dice “la poesia deve essere poesia associativa”, nel senso che deve unire e distinguere, esprimere e omettere, collegare e smantellare, insomma “associare le cose invece che descriverle o spiegarle”. Crede che la poesia stia prendendo una piega piuttosto “anacronistica” ed è d’accordo con gli esperti della tavola rotonda di “Fiumi di poesia” quando afferma che “la poesia del secolo scorso è utile come spettro, come fantasma di un passato ormai morto ma sotterrato malamente, senza le giuste precauzioni: il rischio è la permutazione costante, il rischio è trasformare la poesia in un simbolo talmente stracolmo da essere vuoto, morto appunto”. Fare poesia significa, secondo Z, “parlare con quei morti, dialogare con loro senza pregiudizio” e con pregiudizio intende “eccessiva idolatria o arrogante ignoranza”.
Z si riconosce come abitante del realismo terminale e come “frutto della tecnologia del linguaggio”: “noi pensiamo ciò che diciamo”, che significa che “noi pensiamo ciò che possiamo pensare”, le parole, i concetti che possiamo pensare. Proprio per questo, la necessità è quella di riconoscere la realtà di provenienza, accoglierla nella sua forma “aberrante e innovativa” per infine non permutarla ma “cannibalizzarla a parole”, utilizzare la poesia come “piattaforma di hyperlink”, di associazioni “veloci” da leggere come “codici” e non più come “parole”.

“La poesia non è morta” dice Z, “ma è morta l’idea di poesia a cui ancora siamo ancorati con tutte le nostre forze, che abbiamo paura di lasciar andare via del tutto perché con i nostri antenati e precursori – per chi si sente poeta e quindi collega dei precedenti – ha funzionato”. L’immortalità in tanti l’hanno raggiunta proprio così, tramite la poesia: pertanto, cambiare direzione sarebbe un errore oltre che un “tradimento” della tradizione. Ma “il poeta è un traditore”, confessa Z, “perché tradisce se stesso esprimendosi in modo più o meno poetico”.
Il problema principale è che la natura ha cambiato faccia, appunto, il mondo ha voltato le spalle ed è ora di guardarsi attorno e finalmente “decidere di scegliere”: “l’importante è scegliere” dice Z, “e la poesia non è altro se non scelta: anche se autobiografica, anche se intellettuale, anche se politica, la poesia è scelta e per questo attiva e per questo reale e per questo utile”.

Z va avanti e afferma “di questi tempi lo sguardo generale sembra essersi voltato altrove dalla realtà, rivolto in direzione intestina, propria, personale: le guerre che ci circondano non sono un argomento per la poesia, lo sono solo le nostre”. Ma non è tutto perso, non abbiamo ancora perso e aggiunge “la poesia oggi può agire perché è una scelta, ma soprattutto perché è una scelta che può evolversi, cambiare, allontanarsi e riavvicinarsi costantemente”. Z conclude così: “adesso sembra stupido, parlare a se stessi in un mondo che uccide: la poesia sembra una libertà, un vizio, un esempio di tracotanza superflua, quando dovrebbe essere politica, dovere, diritto; la poesia però è altro, è una politica, è un dovere, è un diritto tra tanti, ma è e rimane la libertà”.
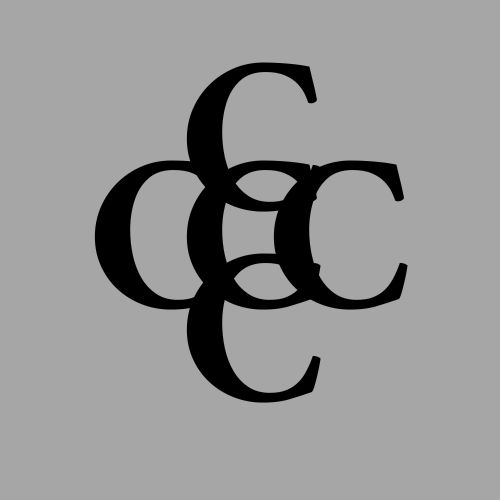

Lascia un commento