Con la morte di David Johansen avvenuta la scorsa settimana, la musica ha perso non solo il leader di una delle tante band x-rock degli anni 70, ma una figura che ha fatto del fallimento un’eredità, della crisi un marchio e della schizofrenia un talento: in questo senso, forse una delle icone più propriamente punk che siano mai esistite, fuori e dentro la musica.

Un pasticcio postmoderno criticato
Partendo dalla fine: l’album New York Dolls dei New York Dolls esce nel 1973 ma è un fallimento totale. Si ritrova al 116° posto delle classifiche americane mentre nemmeno sfiora quelle britanniche. Eppure lì dentro si trova di tutto, un cocktail per tutti i gusti: la vitalità energica e trascinata al tempo stesso degli Stones, la perversione dei Velvet, la rabbia degli Stooges, la fluidità androgina di Bowie e di Bolan e il blues del sud afroamericano. Questo aspetto lo si legge in ogni recensione dell’album: qualche sinonimo qua e là ma il punto è sempre lo stesso. Ora sembriamo tutti d’accordo. New York Dolls lungi dall’essere un mash-up, perché è più un pasticciaccio, un pot-pourri stravagante, sconveniente e di classe al tempo stesso. Una fricassea citazionistica degna del postmodernismo di qualche anno seguente.
Tuttavia, la critica del tempo non guardò a quei ragazzi dalle pettinature settecentesche, vestiti in abiti femminili, tacchi alti e truccati distrattamente con gli stessi occhi con cui li guardiamo noi ora. Le lotte, da più fronti, hanno raggiunto grandi traguardi nel frattempo. L’immagine al tempo doveva sembrare semplicemente quella di un collage bizzarro di idoli per adolescenti e disadattati che ha preso forma in una cover band sgangherata degli Stones. A tutti parevano una loro copia sbiadita e così l’album si infossò sempre di più nelle classifiche finché la band, già equipaggiata di problemi interni dovuti perlopiù all’abuso di sostanze, si sfaldò fino a sciogliersi definitivamente, poco dopo il lancio di un secondo album.

Questa però non è l’immagine che vorrei rivangare dei New York Dolls che, come bambole di altri tempi, sbiadite e rovinate dal tempo, vengono guardati dall’alto al basso a fronte di esperienze musicali più mature venute dopo la loro. Anche perché, spesso e volentieri, come anche Vivienne Westwood e la stessa filosofia punk insegna, la bellezza non è che il frutto di una tempesta caotica e a tratti sterile venuta prima. Lo sguardo sull’album deve farsi più attento e cauto perché, in casi come questi, la vera rivoluzione è quasi impercettibile ad orecchio nudo.
Un album di tematiche mondane
Il contesto di New York Dolls è quello poco successivo al Sessantotto: anni di estroversione reazionaria e anni di introversione intellettuale. L’album caccia fuori una lista di tematiche caldissime al tempo ma lo fa con la noncuranza di chi non è completamente a suo agio a parlare di diritti ma che al contempo sa perfettamente di averne. Il brano più celebre della band, prima traccia dell’album, è Personality Crisis: un urlo iniziale e tanti altri in mezzo a parole che comunicano, che lasciano qualcosa ma che dicono fino ad un certo punto.
Hoping for a better day to hear what she’s got to say
All about that, personality crisis, you got it while it was hot
But now frustration and heartache is what you got
That’s why they talk about personality
L’argomento viene trattato con leggerezza e rabbia allo stesso tempo: la gioventù sa di essere parte di un grande cambiamento ed è consapevole delle proprie libertà, le stesse che possono portare alla più frustrante e dolorante delle crisi. Un giorno ognuno saprà chi è, forse, e passerà il mal di testa, passerà la disillusione, finché quella personalità in crisi tra il diritto al cambiamento e il diritto all’equilibrio non inizierà a mescolarsi con tutto il resto.
Ed è qui che arriva Looking For A Kiss, un brano sulla certezza, sulla sicurezza delle proprie volontà e dei propri desideri.
Well, listen when I tell you, you got no time for fix
‘Cause I just gotta make it, can’t afford to miss
And there’s one reason I’m tellin’ you this
I feels bad, and I’m looking for a kiss
Dopo una tematica di critica sociale, il blues torna in sé parlando di amore non ricambiato, ma poi di nuovo torna sulla realtà, sebbene sempre in termini piuttosto allucinati e controversi con Vietnamese Baby: l’idea è che l’individuo trovi se stesso nelle grandi lotte, nei grandi pensieri, nei grandi problemi della società in cui vive, i quali ci danno l’opportunità di ottenere “tutto ciò che avremmo sempre voluto” senza mai sapere di che cosa si trattasse davvero. A volte basta “a Vietnamese baby on your mind” e tutto il resto scompare, tutti i dubbi sfumano e la realtà si fa più catastrofica, più tremenda e cruenta, ma comunque più vera.
Well, maybe they’re just giving you all you’ve ever wanted
And maybe you never-ever know what that was
And maybe you’re just finding it out now
With a Vietnamese baby on your mind
Per ora l’album si è mosso su ritmi velocissimi che non lasciano il tempo di capire che cosa sta succedendo e che cosa David Johansen, il cantante, sta effettivamente dicendo. I testi non hanno un senso immediato – forse non ce l’hanno affatto – quindi non basta scorrerli mentre la musica va avanti, perché ne esce ben poco, che è forse tutto ciò che dovrebbe uscirne. Ecco che il tono si fa più malinconico con la ballata Lonely Planet Boy, dove David canta frasi mozze come se stesse singhiozzando davvero dalla tristezza, e Subway Train, un manifesto della solitudine metropolitana.
Oh, you pick me up
You’re out drivin’ in your car
When I tell you where I’m goin’
Always tellin’ me it’s too farBut how could you be drivin’
Down by my home
When you know, I ain’t got one
And I’m, I’m so all alone

L’unica cover nell’album è Pills – io nemmeno l’avevo riconosciuta –, brano di Bo Diddley. L’ironia dell’originale qui diventa lo sfogo iracondo di un uomo nel corridoio di un ospedale psichiatrico. Anche in questo caso la tematica è vaga ma c’è e per certi versi si lega al resto della storia precedentemente ascoltata, a partire da Personality Crisis stessa. La vicenda si fa cruda, quasi straziante ma l’atteggiamento rimane, come si suol dire, piuttosto rock n roll a riguardo.
As I was lying in a hospital bed
A rock n roll nurse went into my head
She says, hold ya arm, stick out ya tounge
I gots some pills I’m gonna give you somesShe went into my head, into my head
A rock n roll nurse, went into my head
Il brano, a mio parere, più intenso dell’album è Frankenstein: la storia di Mary Shelley viene ripresa nel suo aspetto più malinconico, ovvero quello di un essere postumano che vorrebbe essere amato ma che non trova riscontro in quello che dovrebbe essere un mondo più umano di lui. La domanda allora è chi sia davvero il mostro. Il protagonista del brano si definisce “incompreso come Frankenstein” mentre cerca di convincere l’altra persona a provare qualcosa per lui che sia vero e autentico, come lui, creatura da laboratorio, paradossalmente invece riesce a fare.
Is it a crime, is it a crime
For you to fall in love with Frankenstein?
Is it wrong, could it be wrong
Wrong, baby, don’t you want a friend?
‘Cause you’re trying to be so selective
You never realize the whole time
Who’s the one you’re loving
Misunderstood like a Frankenstein
And down, down, down, just off the desk
Like Frankenstein, like Frankenstein
Alla fine del brano tutto questo senso di incomprensione e di frustrazione, costante per l’intero album, prende la forma di un urlo che si chiede “Do you think that you could make it with Frankenstein?”.
I brani Trash e Private World sono la risposta anti-letteraria al disagio di tutta questa storia: un mostro non amato si fa spazzatura, si butta via nel momento in cui il dottore lo scopre con un coltello in mano, forse nel tentativo di uccidersi; dopodiché, se la speranza è l’ultima ad andarsene, c’è sempre l’opportunità di crearsi un mondo tutto proprio, quello adatto a chi “ha appena perso il proprio amore”. Tuttavia non è un mondo delle favole anzi, somiglia piuttosto ad un bidone dei rifiuti dove il protagonista è infreddolito e solo mentre “si piange addosso” dispiaciuto per se stesso.

L’ultimissimo raggio di luce lo dà Jet Boy che però è chiaramente un’allucinazione che contiene un certo sapore iracondo verso questo individuo che se ne va, in un posto “dove a nessuno importa di sapere per cosa tu stia vivendo”: un’anticipazione – ma anche una risposta – a Boys Don’t Cry è proprio “Jet Boys fly”.
This the kinda place where no one cares
What your livin’ for
And Jet Boys so preoccupied
He don’t care ‘bout before, and that’s whyJet Boys fly, Jet Boys gone
Jet Boy stole my baby
Flyin’ around New York City so high
La più grande truffa del rock’n’roll
Quest’album, che lo si voglia o no, ha cambiato la storia del rock senza nemmeno posizionarsi in classifica. Un bell’avvertimento rispetto alla differenza tra musica e industria musicale. New York Dolls fu fondamentale per coloro che vennero dopo, dal glam rock stesso, all’hair metal, all’alternative metal, al glam punk e a tutta la corrente new wave, finanche lo scan rock. Per non parlare dell’androginia estremizzata e disarmante con la quale i New York Dolls si sono presentati sui palchi. L’aspetto iconico in tutto questo, come spesso accade, è l’inconsapevolezza di un sound provocatorio e caciarone come il loro pur sempre radicato nel cuore della musica blues.
Questi magrissimi divi metropolitani hanno avuto la sfacciataggine di affrontare tematiche notevoli senza il benché più minimo riguardo, ma con la semplice consapevolezza di chi si ritrova in una realtà come quella newyorkese in cui accade di tutto ma in cui nulla passa davvero inosservato. Senza troppi giri di parole, i New York Dolls parlano di malattia mentale, guerra, violenza, psicofarmaci, suicidio, depressione e crisi identitarie attraverso uno schema comunicativo postmoderno: l’impressione è quella di avere la televisione accesa sul notiziario mentre si sta facendo qualcos’altro, per cui si sentono parole qua e là, discorsi qua e là, da riportare poi filtrati dalle proprie percezioni in conversazioni mondane.

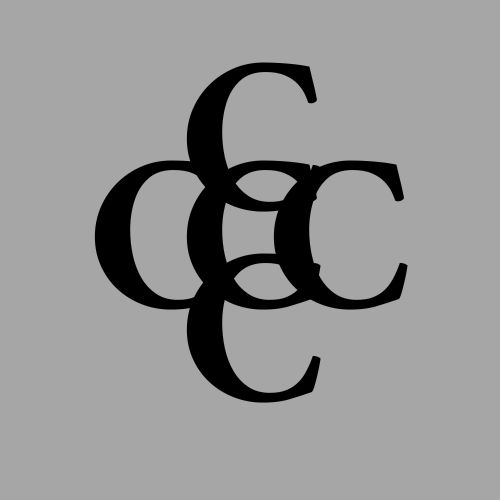

Lascia un commento