A due giorni dalla morte di Roberta Flack, spentasi all’età di 88 anni dopo tre anni di lotta contro la SLA, è importante ricordare la storia e il significato di un capolavoro che ha portato la grande interprete R&B al successo negli anni 70 ma che soprattutto insegna ancora tutt’oggi cosa significa morire, fuor di ogni senso fisico o biologico, sentirsi morire a causa della tragicità universale della propria storia.

Una catena infinita di dolci morti
Notata per la prima volta alla fine degli anni 60 al Mr. Henry’s, locale notturno dove si esibiva al pianoforte, Roberta Cleopatra Flack fu ingaggiata immediatamente. Iniziò a lavorare al suo primo disco e galeotto fu il volo del 1972 da New York a Los Angeles dell’American Airlines durante il quale ascoltò per la prima volta, e poi quattro volte di fila, Killing Me Softly. Il brano fu composto e interpretato da Lori Lieberman, cantautrice californiana che non resistette alla tentazione di mettere per iscritto l’emozione provata durante l’ascolto live di Empty Chairs. Il brano di Don McLean racconta in termini estremamente vividi, sottoforma di ninna nanna, un addio a parole inaspettato: il dolore provato nel momento in cui il verbo si fa carne.
Il mattino arriva e il mattino passa senza rimpianti
La sera porta con sé ricordi che non posso dimenticare
Stanze vuote riecheggiano mentre salgo le scale
E vestiti abbandonati che cadono su sedie vuoteE mi chiedo se tu sappia
Che non ho mai davvero capito
Che, anche se dicevi che saresti andata via
Fino a quando non l’hai fatto davvero
Non ho mai pensato che lo avresti fatto(Empty Chairs, Don McLean)
Roberta Flack cantò il brano non appena giunta a Los Angeles. Si aprì così una catena infinta di morti dolcissime.
Un giovane ragazzo americano è il primo a morire della lunga catena, ma fa in tempo a incidere l’abisso dell’abbandono per mezzo di una semplice metafora – quella di due sedie vuote – che regala durante una performance emotivamente complessa; assiste al momento una giovane cantautrice americana che è però la prima a riconoscervi un senso di morte, un allontanamento sottile, cullante e costante dalla vita mentre la si ascolta raccontata da terzi senza poterci fare niente, senza poter in alcun modo intervenire; dopo di lei, un’artista emergente è strappata alla realtà concreta e rumorosa di un viaggio in aereo proprio a causa delle stesse parole e della stessa sensazione di essere stata scoperta nelle sue sofferenze più recondite; infine noi, che forse conosciamo la versione dei Fugees o forse nemmeno quella, ma che, una volta ascoltata, non possiamo più tirarci indietro.
Ci voltiamo e scopriamo di avere mani, piedi e testa legati indissolubilmente alla catena di una morte dolce, una morte emotiva e lenta che supera di gran lunga i cinque brevi minuti del brano.

L’ars moriendi
Tornando un po’ tanto indietro nel tempo, si definisce con la locuzione latina ars moriendi un genere letterario fatto tradizionalmente iniziare con due scritti latini composti nella prima metà del XV secolo, tra il 1410 e il 1450, poco dopo il flagello della pandemia di peste nera, diffusasi in Europa durante il secolo precedente (1346-1353). Si tratta di manuali per il giusto vivere e il giusto morire, a partire dall’imitatio Christi e i suoi insegnamenti. Morire bene, morire dolcemente è possibile, basta seguire alla lettera i passaggi corretti senza farsi scappare nulla. In un’epoca dove l’individuo “si sentiva morire” quotidianamente, l’aspetto fondamentale dell’esistenza terrena era rappresentato dal costante e incessante promemoria della fragilità umana.
Con l’ars moriendi morire non è più un male, la morte non è più un territorio ignoto, un momento di eterno rimpianto nell’angoscia e nell’incertezza del giudizio universale, della scelta tra Inferno e Paradiso. “Coloro che fanno filosofia in modo corretto si esercitano a morire”, coloro che rivalutano se stessi, coloro che riflettono sul proprio percorso e su ogni singolo passo del proprio cammino possono ben sperare di trovare la strada per il perdono, innanzitutto, di se stessi. L’importante è rimanere attenti, e se anche ciò non dovesse essere possibile, sarà il ricordo della finitezza a trovarci, ovunque noi saremo: la fragilità dell’esistenza non si nasconde nemmeno troppo bene, è possibile riconoscerla banalmente in un lutto improvviso, nella fine di una passione, nei versi di un libro, nello scaricarsi della batteria dell’auto così come nelle parole di una canzone.
L’attenzione è il sentiero verso il non morire, la disattenzione è il sentiero della morte. Gli attenti non muoiono ma coloro che sono disattenti sono come già morti.
(Dhammapada, p. 30.)
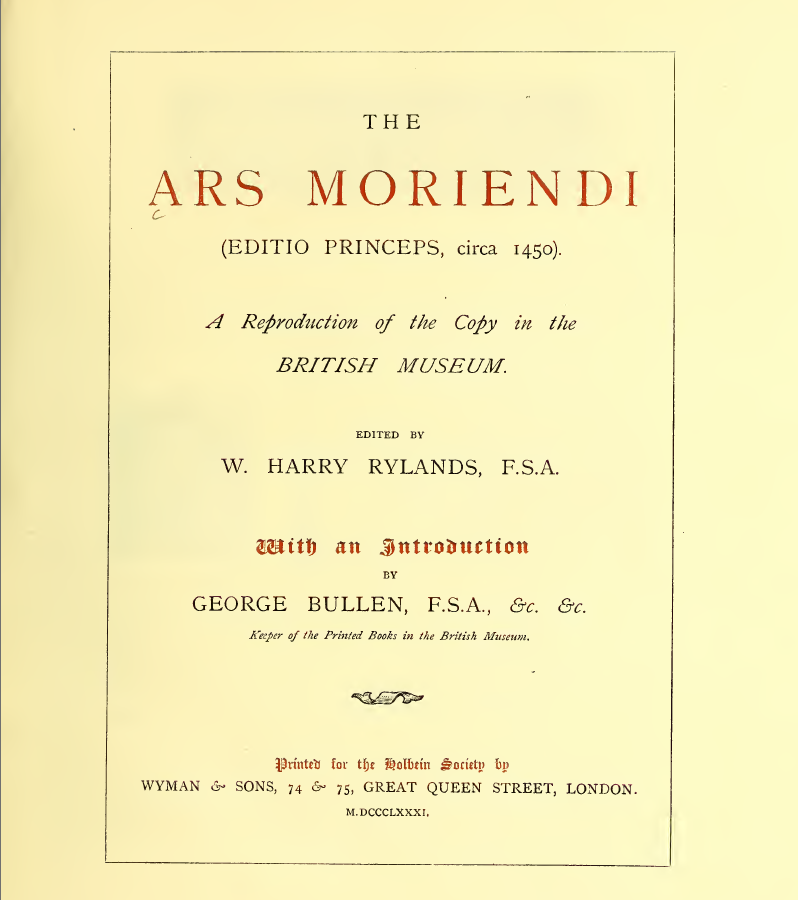
Pregavo finisse presto ma invece continuava a cantare
Una ragazza entra in un locale. È distratta, chiacchiera con i suoi amici e beve qualcosa. La luce è soffusa e c’è nebbia. Non fa nemmeno così freddo, o così caldo, non c’è tanto di cui parlare ma è necessario parlare se si è in compagnia. Oppure no. La ragazza entra in un locale. È sola. È sovrappensiero, non è distratta, anzi è molto attenta ma di quell’attenzione figlia della solitudine. Un’attenzione arrotolata su se stessa come un intestino che è paradossalmente in tensione e piegato su se stesso al contempo, attento a ciò che entra ma non a ciò che esce. Una brutta immagine forse, ma rende l’idea, forse.
Viene presentato qualcuno sul palco, un giovane uomo sconosciuto e anonimo, mentre lei scorre il dito lungo bordo del bicchiere e guarda il ghiaccio mentre si scioglie. Non sente niente che non provenga dalla sua testa. È attentissima. Il bicchiere è trasparente ed è triste vedere il ghiaccio sciogliersi. È una scena tragica, resa così pubblica da un vetro così spesso da ingrandire gli oggetti e così trasparente da consegnare lo spettacolo della morte in pasto a chiunque sia di passaggio.
Comincia la musica e questo la distoglie, ma nulla di ché. Poi però ci sono le parole che accompagnano la melodia. Ecco il problema. Le parole. Si sente una “bella canzone”. Il ragazzo ha “uno stile tutto suo” ma rimane “un ragazzino” sconosciuto, “estraneo”, mai visto prima. Eppure è impossibile non ascoltarlo.
Strimpella il mio dolore con le sue dita
Canta la mia vita con le sue parole
Mi uccide dolcemente con la sua canzone
Mi uccide dolcemente con la sua canzone
Raccontando tutta la mia vita con le sue parole
Mi uccide dolcemente con la sua canzone(Killing Me Softly, Lori Lieberman)
La ragazza è confusa. Ora sente caldo, inizia a sudare ma trema dal freddo. La febbre sta salendo e il suo intestino, la sua solitudine ora avvampano, bruciano e il fuoco è troppo luminoso per guardarlo. È impossibile non notarla, in preda a se stessa, perciò si guarda attorno. È a disagio tra il pubblico. Chi è stato? Nessuno! Quel nessuno l’ha tradita, eppure nemmeno si conoscono. Quel nessuno lei non l’hai mai visto prima.
La ragazza vede srotolarsi davanti a sé come un infinito rotolo di papiro la sua intera storia. La sensazione è terribile, è simile ad un tradimento. Sì, ecco, un tradimento. Era come se quel ragazzo avesse trovato tutte le sue scartoffie, i suoi pensieri scritti, le sue lettere, i suoi appunti, e li avesse letti di nascosto per trarne una canzone da cantare pubblicamente, a voce alta, davanti a tutti. Era come se il suo mondo più intimo e oscuro fosse stato consegnato in stampa. Era come assistere al proprio funerale.
Per tutti era una canzone e basta: dall’interpretazione così coinvolta e dalla voce così potente del ragazzo, chiunque avrebbe pensato si trattasse di lui, della sua vita, della sua storia. Ma la ragazza lo sapeva, quella vita, quella storia, era la sua.
Ero pervasa da un calore febbrile
A disagio tra la folla
Era come se lui avesse trovato le mie lettere
Per poi leggerle una ad una ad alta voce, davanti a tutti
Pregavo finisse presto
Ma lui invece continuava a cantare(Killing Me Softly, Lori Lieberman)

Le cose che raccontava, le parole che pronunciava, la malinconia che trasmetteva, proveniva tutto da lui? Parlava così concretamente di cose a lei troppo vicine, troppo intime. Cose che non aveva mai detto a nessuno. Cantava come se la conoscesse, come se avesse potuto avere a che fare con lei, per tanto tempo, tutto il tempo necessario per conoscere la sua cupa disperazione.
La ragazza era immobile, come congelata, mentre pensava al fatto che quello sconosciuto le aveva appena rubato l’anima. Le aveva incredibilmente rubato tutto, aveva tradito tutti i suoi segreti mai confessati, tutte le sue emozioni mai trasparite, e senza né giudizio né curanza li aveva copiati e incollati su una melodia per intrattenere un pubblico in una serata qualunque. Mentre pensava, il ragazzo incrociò il suo sguardo ma i suoi occhi le passarono attraverso: la guardava senza quasi vederla, come se fosse invisibile.
Avrebbe voluto sprofondare sotto terra tanto fulminante le sembrò quello sguardo che però, velocemente, si spostò sulla folla, come se nulla fosse. Non si sarebbe mai sognata di alzarsi e andarsene. Quella storia era sua e la rivoleva indietro. Quel ragazzo non avrebbe mai più dovuto usarla a suo vantaggio, le apparteneva di principio. Ma lui continuava a cantare, ignaro, mentre lei pregava che il brano finisse, che la gogna si concludesse e che finalmente la sua testa venisse tagliata con un solo gesto. Ma no, quella morte era tremenda: dolce come una canzone e lunga come un bacio del tradimento.
Cantava come se mi conoscesse
In tutta la mia cupa disperazioneE poi mi ha guardata come se fossi invisibile
E ha continuato a cantare
Con voce limpida e potente(Killing Me Softly, Lori Lieberman)
Una necessaria procrastinazione
Il ricordo della finitezza ci raggiunge dappertutto, ovunque noi siamo. Forse, chi ha un conto in sospeso con se stesso si esercita a morire ma non muore mai, mentre tutti gli altri sono già morti. L’anonimo che strimpella il nostro dolore è potenzialmente ad ogni angolo e l’arte è essa stessa ars moriendi.
L’autore, traditore di mestiere, ci insegna il buon morire, quello di chi è attento alla fragilità della propria esistenza e di quella altrui. Il fatto che un brano così ontologicamente autentico, nato da un’ispirazione fugace e immediata, trasmetta tutt’ora un messaggio così universale e così facilmente declinabile, aperto a mille e una tematica, rappresenta per eccellenza il valore artistico dell’immortalità e ciò di cui il male – come dolore – umano è capace.
Killing Me Softly è la storia di un tradimento necessario, proprio perché inconsapevole. Un vangelo al contrario, dove Giuda non è il traditore, ma piuttosto “la vittima di un curioso piano di salvezza esteso a tutti gli uomini”, possibile ed esplicabile in tutta la sua perfezione a patto che il traditore ne rimanga escluso, l’unico che però muore davvero. Ad ogni modo, se l’immortalità esiste davvero, chi muore in un brano vive per sempre, o meglio, chi muore in un brano muore lentamente, e una morte così prolungata e trascinata nel tempo, è una vita eterna, una dolce e necessaria procrastinazione. Ecco la vera imitatio Christi. Ecco la vera ars moriendi.

Riferimenti
Dhammapada. Trad. it. di G. Pecunia. 2011. Feltrinelli.
Platone. Fedone. Trad. it. di S. Martinelli Tempesta. 2011. Einaudi.
Pomilio, M. Quinto Evangelio. 2022. Bompiani.
Tenenti, A. Il senso della morte e l’amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia). 1977. Einaudi.
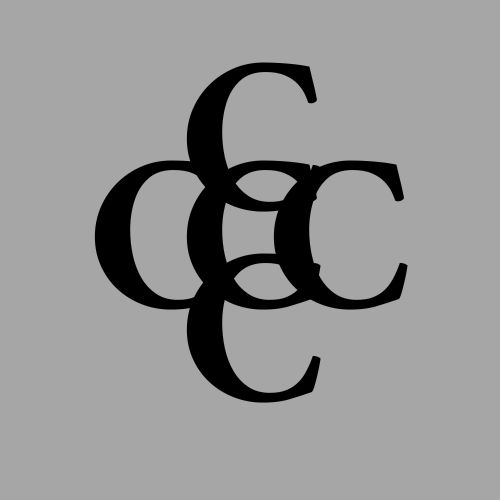

Lascia un commento