Premessa al lettore: questo è uno speciale, un ritratto in dieci punti dell’ultima edizione del Festival visto da un punto di vista molto marginale: il mio. Mi sono resa conto di quanto un tale spettacolo sia in grado di far esistere – visibilmente sullo schermo – cose che altrimenti resterebbero impalpabili, polveri sottili che però riassumono gran parte della nostra inconsapevole quotidianità. Non è esattamente il tipo di contenuto per cui questa rubrica è nata, ma ho ragionato su quanto si possa guardare il Festival leggendovi e immaginandovi altro.

Sanremo quest’anno ha raccontato, volendo o no, dieci piccole micro-società che convivono nella nostra realtà italiana e universale. Queste le ho personalmente immaginate e raccolte: classifiche, commozione, fantasmi, oggetti, spettacolo, ricordi, felicità, ripensamenti, cantautorato e partecipazioni sono i nomi che ho voluto dare loro. Non è una recensione, appunto, ma un ritratto che può dare spunti per ragionamenti e divagazioni verso altri discorsi che, alla fine, riguardano o meno il Festival della Canzone Italiana.
#1 – La società delle classifiche
Argomentare una top 5
L’hanno fatta tutti, l’ho fatta anche io in veste di redattrice de La Casa del Rap, e la rivendico. In questo caso però ho pensato di approfondire un po’, argomentare le mie cinque scelte, partendo in particolar modo dalla mia personalissima ossessione: i testi.
Lucio Corsi ci ha regalato Volevo essere un duro, una ballata in stile un po’ Zero, che ritrae la figura di chi in fondo sa dove sta andando ma non vuole per questo rinunciare a se stesso, ammettendo di aver anche pensato di far finta che il futuro fosse poca cosa e che la vera colpa non è del tempo perso ma del tempo stesso, quello che ci lascia indietro. Qualcuno ha parlato di inno degli outsider ma credo sia riduttivo: Lucio ha portato sul palco il piacere del canto e della musica, sottoforma di piacere del raccontare il machismo subìto dagli uomini attraverso una certa (auto)ironia un po’ vintage con la forza di uno scapigliato milanese di metà Ottocento.

Però non sono nessuno
Non sono nato con la faccia da duro
Ho anche paura del buio
Se faccio a botte le prendo
Così mi truccano gli occhi di nero
Ma non ho mai perso tempo
È lui che mi ha lasciato indietro
Brunori Sas è davvero “un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere” ma è anche un pittore impressionista che, come Monet ha fatto con la Cattedrale di Rouen, ci ha proprio messi di fronte a L’albero delle noci che sta davanti a casa sua, vigile su “questi anni feroci” che “sono passati veloci”. Come lui stesso lo ha definito, il brano rappresenta “l’altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l’adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell’ombra”. Un po’ come ha fatto anche Tedua nel suo freestyle sul palco Suzuki – al punto #9 se ne parla –, Brunori Sas ha raccontato all’Ariston il mestiere del cantautore con poetica e trucida verità, quello di un artigiano che l’amore a volte non lo riesce proprio a sostenere e che vorrebbe “cambiare la voce”, a volte vorrebbe addirittura “cantare senza parole, senza mentire” per evitare di far soffrire.
Brunori ha anche fotografato la sua terra, la Calabria – ma il mondo intero, in realtà –, “una terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine”. Sicuramente Brunori Sas è un esempio per i nuovi cantautori senza essere un fantasma – rimando al punto #3 per questo – proprio perché ha dimostrato come, fuor di animismo, anche un albero raccoglie storie autorevoli su di noi.
E tutta questa felicità forse la posso sostenere
Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore
Shablo ha invece fatto qualcosa di incredibile, una rivoluzione dietro l’altra: innanzitutto il rap a Sanremo – Guè che in camera dice “amo sti money”, surreale –, in secondo luogo il caso Tormento-Neffa e infine, punto su cui mi vorrei concentrare, il mondo degli underdog tra i blocchi di cemento. La mia parola è una “street song” che dà tutto ciò che ha, un brano che porta sul palco la certezza periferica di chi “nonostante tutto mette da parte i forse”. Non a caso è chiamato in causa il mondo black – il videoclip è un meraviglioso esempio di tributo alla sottocultura –, il mondo radicato nella disperazione di vite cicliche, di gente che “muore e vive”, troppo velocemente sotto nuvole di smog e mura di cemento.
Personalmente, ritengo che portare a Sanremo il mondo “senza alternative” raccontato da tre generazioni di rapper sia un messaggio oltremodo chiaro e forte: ci fosse anche qui un albero delle noci direbbe che in fondo tutto è rimasto com’è. Forse è poco rilevante ma, casualmente o no, la riproduzione casuale dei miei brani preferiti su Spotify riproduce I am a Steady Rolling Man di Robert Johnson subito dopo La mia parola. Non aggiungo altro.

Suona dal basso questo gospel
È la voce di chi raccoglie le forze
Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte
Noemi – non premiata abbastanza nell’ultima classifica – con Se t’innamori muori ha portato al Festival il tema del perdono e dell’ars moriendi propriamente femminile e lo chiamo così perché racchiude in sé un mare di certezze, dubbi, perplessità e consapevolezze. Il testo, accompagnato da un bellissimo arrangiamento, “racchiude l’importanza di vivere la vita senza particolari paure”. Sicuramente, il messaggio dell’“abbandono sereno” che si prova quando ci si innamora, arriva, e non è facilmente spiegabile, se non dicendo che descrive la vulnerabilità che accettiamo nel momento in cui decidiamo di darci all’altro. Tutti quei discorsi di coppia che portano alla stanchezza, alla volontà talvolta di “lasciare sempre perdere”, di avere figli o no, “l’ansia se si allungano i silenzi” e l’agrodolce verità che alla fine “qualcuno dovrà perdere”. L’importante, perché le cose durino, è “lasciarsi perdere”, dimenticarsi del sé proprio e di quello altrui e morire, infine, “serenamente”.
Perché è impossibile scordare quelle notti,
Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,
La sensazione che se ti innamori muori
Serenamente.
Infine Bresh, che dire di La tana del granchio che ha involontariamente toccato corde per me difficilmente descrivibili. L’intro fa respirare Genova da subito, la tremenda malinconia di fine estate, quella di chi però vive in una città di mare e che quindi deve inevitabilmente affrontare tutti i giorni il ricordo della leggerezza estiva.
La ballata di Andrea Emanuele Brasi è personalissima e fortemente enigmatica: c’è una tana, una canzone e un dubbio, volendo tre sinonimi di “rifugio”, uno di quelli perfetti per “una sirena che non nuota”, un’anima che non ha un programma di cura, che non sa quando guarirà perché continua ad avere davanti agli occhi, immobile e indifferente, un contenitore di lacrime salate dei marinai: il mare. Probabilmente Bresh aveva in mente qualcosa di diverso da ciò che scrivo io qui, ma il cantautorato e l’ermetismo permettono tutto, forse anche interpretazioni come queste, da due lire. Mi perdonerà.

Sono una madre che si sgola
Una testa che gira ancora
Una chitarra che non suona
Una borsa piena di buchi
Se capisci che non ti amo
Sei una sirena che non nuota
Cosa puoi dire
Fammi solo sapere quando vuoi guarire
Dall’espressione hai qualcosa da dire per me
Ma lo sento non mi dai due lire
#2 – La società della commozione
La commozione è un valore?
Due protagonisti maturi della disciplina cantautoriale che hanno gareggiato nell’edizione di quest’anno sono Simone Cristicchi e Brunori Sas. Tantissime sono state le ri-condivisioni sui social e sui gruppi whatsapp – familiari soprattutto – del brano di Cristicchi che è andato a toccare una corda spesso un po’ dimenticata nella quotidianità, ovvero gli anziani, o meglio, il rapporto tra figli maturi e genitori ormai anziani. Dediche di figli grandi ai propri genitori, dediche di genitori anziani ai propri genitori deceduti, dediche lungimiranti di giovani ragazzi ai loro genitori, e così via. L’aspetto comune a tutti questi quadretti: la commozione. La stessa che, personalmente, ho invece provato dal primo all’ultimo ascolto di L’albero delle noci di Brunori Sas. Ammetto che con Quando sarai piccola non è successo lo stesso.
La commozione è un fenomeno interessante: è intima e collettiva al tempo stesso. A volte è figlia del buon senso, di un sentire comune innegabile e invalicabile. Altre volte è il frutto di un periodo particolare della nostra esistenza: ciò che una volta ci lasciava indifferenti, a distanza di tempo ci commuove. La mia domanda però è: la commozione è un valore? Se qualcosa, come una canzone o un quadro, ci fa piangere, significa che è valido? Non sono sicura di riuscire a rispondere con certezza e autorevolezza a questa domanda, però una cosa la so.
Benjamin distingueva in campo artistico gli autentici dalle riproduzioni. Un’opera originale è caratterizzata da un’“aura”, ovvero un legame con la storia e il contesto di produzione dell’opera stessa, che la lega indissolubilmente al suo passato. Le copie invece no: non racchiudono alcun valore di autenticità, non sono che riproduzioni che però possono diffondersi facilmente e velocemente. Le copie guadagnano allora un altro tipo di valore, ovvero quello della capacità di insinuarsi nelle fessure di ogni porta e finestra, fuori di metafora, ogni presente, anche quelli che l’opera d’arte autentica – per forza di cose – non può fisicamente raggiungere.
Cosa c’entra allora questo discorso con la commozione? Il caso di questi due brani e la commozione che suscitano mi hanno fatto riflettere sul concetto di valore artistico: un’opera è grande perché quella volta lì, in un preciso istante, ci ha commosso o perché riesce a farlo in qualsiasi momento della nostra vita, in qualsiasi nostro personale presente? Ha più valore il ricordo della commozione o la commozione stessa? Consiglio di porsi questa domanda riascoltando i due brani. Allora forse una risposta alla mia domanda emergerà. Per ora, mi ritengo ancora troppo giovane per saperne qualcosa.
#3 – La società dei fantasmi
Il fantasma di Califano
La prima sera Achille Lauro si è presentato nei panni di un Rodolfo Valentino tormentato, un calco di Califano costante ma per nulla macchiettistico il suo: un cattivo dall’animo buono, un amante d’altri tempi insomma, qualcosa che abbiamo già visto molte volte nelle sue performance più recenti e che comunque continua a piacerci – perlomeno, personalmente. Dall’altra parte invece, oltre la metà della prima serata è arrivato Tony Effe: si era pensato tutto e niente di lui, tutto e niente tranne ciò a cui abbiamo assistito. Tony si è presentato con una ballata tradizionale dedicata a Roma – o ad una donna, vecchio gioco di immagini e metafore – riprendendo a modo suo il leitmotiv del sinno me moro. L’immaginario tocca di nuovo a pieno quello del Califfo.
Se entrambi – come tanti altri quest’anno – hanno portato sul palco l’amore tossico, Lauro lo ha fatto in stile suo che definirei epicsessed – visibilmente contemporaneo ma con quella costante ossessione per l’epicità di ogni verso, qualcuno direbbe poser –; Tony invece ha portato il tormento dell’uomo d’onore, l’uomo dall’io diviso tra dovere e cuore, pur sempre nella romantica cornice della città eterna. Tony ripropone Califano anche nella serata cover, questa volta assieme a Noemi: purtroppo non ho percepito né malinconia, né rassegnazione, né strafottenza, ma va bene così. Tra l’altro, anche Willie Peyote ha scelto Califano per la serata cover.

I fantasmi non sono che proiezioni, ossessioni, presenze inquietanti e costanti della memoria personale e di quella culturale, quindi condivisa. In questo caso, il fantasma di Califano è aleggiato tantissimo quest’anno e spesso mi chiedo quanto gli spettri degli artisti deceduti siano importanti per noi. Nel mondo musicale, ad esempio, i fantasmi sono fondamentali, spesso sono il motore dell’ispirazione artistica stessa – a questo proposito consiglio Rosso Floyd di Michele Mari – ma il loro unico difetto è che sono trasparenti, per rivivere vanno cioè riempiti di sostanza o linfa nuova. Questo a volte succede e a volte no.
Sicuramente Sanremo è un’ottima occasione per provarci ma risulta comunque necessario tenere sempre a mente che i fantasmi, quando sono idoli o modelli di riferimento, non vanno riportati in quanto tali, perché da fuori si vede. È necessario farli uscire dalla propria cameretta, vampirizzarli con mano ferma e delicata – e rimando di nuovo a Mari per questo – e solo dopo utilizzarne il sangue per riportar loro e se stessi in vita. Concludo però proponendo una piccola osservazione simpatica: Tony e Achille sono stati i preferiti di mio nonno, classe ’37. Probabilmente, a suo avviso, tutta la questione del fantasma troppo idolo e poco tributo nemmeno c’era. Forse le mie sono tutte congetture.
#4 – La società delle cose
Il collana gate e altri oggetti
Una kermesse che si rispetti non è mai priva di gates, ovvero inconvenienti diplomatici. Quest’anno in effetti ha fatto parlare di sé – come ci si poteva aspettare d’altronde – Tony Effe e i suoi tatuaggi rimossi con il fondotinta e il cosiddetto “collana gate”. Dopo la seconda esibizione, l’artista è stato consolato da Ema Stokholma e Gino Castaldo nello studietto di Rai Radio 2, dove si è sfogato raccontando che, poco prima della sua esibizione, gli è stata “tolta” la collana. Tony argomenta che è come aver rasato i capelli a Sansone – ed è anche un po’ incerto sulla similitudine ma in realtà va bene, funziona – e continua “mi hanno tolto i poteri”.
Un conto è quando i poteri ce li togliamo da soli, perché vogliamo mostrare volontariamente una parte vulnerabile della nostra personalità, come Tony ha deciso di fare per la prima performance di Damme ‘na Mano, mostrandosi sul palco senza tatuaggi, “come voi mi volete” ha detto. Un conto è quando i poteri ci vengono tolti con coercizione e tra l’altro anche con poco preavviso. Ema riporta, non senza personale interpretazione, l’offesa di Tony al dopo Festival dove, parlando con Cattelan, dice che è comprensibile, proprio perché si tratta di un discorso riguardo il “sentirsi a proprio agio” durante una performance.
Le cose, gli oggetti ci riguardano più che mai, ci descrivono e, spesso e volentieri, tendiamo ad attaccarci ad essi trasformandoli in feticci, elementi di valore e significatività importante e ambigua al tempo stesso. Forse la collana non andava tolta, forse Tony, che già si è presentato con i tatuaggi e a torso nudo, si è sentito ancora più nudo, a disagio, non era pronto insomma. Se la prima sera non era il Tony che conosciamo, ecco che per la seconda l’artista aveva programmato di tornare ad essere come noi non lo vogliamo – e gioco sull’affermazione precedente. Chi dice che è un capriccio infantile, forse è vero, ma in fondo non sono proprio i capricci-feticci a rendere le cose più tragicamente umane? Anche i rapper piangono: forse lo sapevamo già, o forse no.
#5 – La società dello spettacolo
L’uomo dietro al gossip
Con Fedez ci aspettavamo di tutto: pianti, litigi in backstage, in generale trash ma BATTITO ci ha invece dato un bel pugno in pancia. Personalmente, ragionando sulla sua prima esibizione, sembrava stesse litigando con l’altra metà di se stesso o chissà, con la parte paranoica della propria personalità, quella che ha “bisogno di troppe attenzioni”.
Naturalmente, il pubblico della società della spettacolarizzazione non si è di certo fatto scappare il suo “prenditi i sogni, pure i miei soldi, basta che resti lontana da me”: si è ampliamente discusso sui social se il brano fosse dedicato a Chiara o ad Angelica, ma un’interpretazione interessante vede il brano dedicato alla malattia. Da una parte avevamo il gossip anticonvenzionale di Corona e il suo Falsissimo, dall’altra avevamo invece Federico che se non stava litigando con se stesso, con Chiara o con la sua malattia, credo allora stesse litigando proprio con noi, con il pubblico delle sue Instagram stories più che dei suoi concerti. Né Corona né – e soprattutto – Fedez ci hanno dato tregua. Anche nella serata dei duetti Fedez e Marco Masini ci hanno regalato l’ennesimo pugno in pancia: mentre il concorrente al Festival ha tremato per tutta l’esibizione e quasi pianto nel momento in cui si è conclusa, Masini e il suo brano sono stati una cornice senza tempo ad una storia che, nel bene o nel male, è davvero attuale e presente, forse un po’ troppo.
Spettacolo, in senso volgare, non ne ho visto. Solo uno uomo che svuota le sue viscere. Il gossip l’ho dimenticato. Forse questa volta ho davvero visto un uomo solo con se stesso e nient’altro.
#6 – La società dei ricordi
Onnivorismo Gen-Z poco cannibale
Il caso AMARCORD non ha fatto parlare tanto, quindi non è affatto un caso. Tuttavia la giovanissima Sarah Toscano ha portato sul palco del Festival qualcosa di tanto agrodolce quanto stridente. “Cos’eri tu non lo so, ma un po’ mi avevi illusa” canta l’ex concorrente di Amici: forse è davvero una reinterpretazione un po’ Gen-Z del capolavoro di Fellini. La mia lungi dall’essere una provocazione. Anzi, al di là del “comico e tragico” che è poco rilevante, trovo sia interessante prendere in considerazione la forza delle illusioni e l’effetto ancoraggio dei ricordi, ovvero come noi li sovrascriviamo e in questo, effettivamente, l’Amarcord felliniano può tornare in mente. “La consapevolezza che indietro non ci ritornerò, e mi faccio tenerezza, un velo di tristezza è l’unico vestito che ho” canta la concorrente. Inizialmente verrebbe da dire ‘lascia perdere’, con quel tono tipico della severità paterna o materna che sia che però, malgrado l’idea di protezione che nasconde, un po’ demoralizza, un po’ le ali le tarpa.

Nei tempi che furono, Calvino recensì Amarcord descrivendolo come “il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori” e che invece “è la storia della nostra vita”, qualcosa che ricorda la sensazione adolescenziale descritta da Sarah Toscano nel suo brano. Non ho la più pallida idea del perché abbia scelto questo titolo, ma ho deciso di parlarne per fare una personalissima retromarcia: se inizialmente ho pensato fosse un po’ too much, ammetto di aver voluto riflettere sulla questione, partendo – come mio solito, d’altronde – dal testo e qualcosa, alla fine, credo di averlo anche trovato. Sicuramente questo caso non-caso ha portato alla luce un certo onnivorismo tipicamente Gen-Z che talvolta si dimostra essere un po’ naif, poco digerito, poco cannibale. Che poi cosa importa? Per come la vedo io, già solo il fatto che il suo brano mi abbia portato a ragionare ancora una volta sul film di Fellini, è un’ottima cosa, della serie che a volte ‘basta che funzioni’.
#7 – La società della felicità
Il tributo a Dalla di Damiano David e tanti altri
Damiano David ha interpretato meravigliosamente sul palco di Sanremo “una canzone per i giovani alla ricerca della felicità”, tanto che il piccolo Vittorio a fianco dell’attore Alessandro Borghi si è anche commosso. In questo senso si inseriscono anche il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio, sulle note di Nel blu, dipinto di blu, e il duetto di Simone Cristicchi e Amara su La cura.
Lucio Corsi ha sicuramente dimostrato un gusto vintage ma innovativo, una cosa difficile da fare, un esempio per il Festival di Sanremo, un tributo alla televisione dell’immaginazione, dei sogni e del fantastico – nel senso borgesiano. Trovo interessante che egli stesso si senta parte di un suo personale immaginario, portando stivali con sotto il nome di Andy, proprietario dei giocattoli di Toy Story. Quindi Topo Gigio non è meno reale di altre persone in carne ed ossa, – così come di Lucio stesso – ma personifica piuttosto la felicità di un oggetto che, come il verbo, tramite la canzone si fa carne.
Aggiungo anche che l’esibizione di Cristicchi e Amara è stata superlativa: ho letto commenti che riportavano parole come “noia” e “tristezza”. Per me invece quell’esibizione ha incarnato la felicità, proprio perché il brano stesso la incarna. Fuori di dichiarazioni d’amore nella serata cover capitata il giorno di San Valentino, credo ci si sia troppo concentrati sul fatto che Amara è la compagna di Cristicchi, quando si tratta innanzitutto di un’artista di esemplare raffinatezza che con il salmo cantato ci ha davvero ipnotizzati, richiamando una lingua semitica come l’aramaico, lingua franca dell’Oriente antico tra Siria, Mesopotamia e Palestina – in un momento storico-politico come questo tra l’altro.

I due hanno portato uno dei brani più emblematici di Franco Battiato, un brano non romantico ma profondamente spirituale, un brano che chiunque avrebbe dedicato alla propria figlia, alla propria madre o alla propria compagna, ma Battiato no. Battiato lo ha forse dedicato alla sua anima, un esempio di profondità che non può che rappresentare felicità nel vero senso di completezza dell’io con le sue schizofreniche parti. Interessante anche il Teatro Patologico che ha portato Simon Boccanegra durante la seconda serata del Festival: “Non fanno altro che buttarsi bombe e perché lo fanno? Perché non hanno la forza di guardarsi negli occhi”, un messaggio sinceramente potente che di nuovo fa luce su che cosa sia davvero la felicità. Ho trovato inoltre fondamentale il fatto che l’ultima parola cantata del Festival è stata la parola “vita” del brano di Olly, Balorda Nostalgia – “però è stata tutta vita” dice l’ultimo verso. Un brano che, come detto da Olly stesso ad Esse Magazine, “parla di una rassegnazione che spera in un nuovo inizio”. Che cos’è, se non questo, la felicità?
#8 – La società dei ripensamenti
I testi da rivalutare dopo il primo ascolto
In questo punto faccio ammenda, proponendo due brani di cui non ho colto il valore autoriale al primo ascolto.
Mille volte ancora di Rocco Hunt è un racconto nostalgico che esprime il dolore di chi è dovuto partire, includendo senza filtri un vero e proprio monito alle nuove generazioni. Rocco porta il dialetto per raccontare il sé bambino che è piuttosto universale, riuscendo così a fotografare con violenza – pur sempre adatta al palco dell’Ariston – un contesto abbandonato dove regna la guerra mentre i sogni si infrangono. Anche la sua, come quella dei suoi colleghi di La mia parola, è una parabola sociale che esprime l’ambivalenza dei sentimenti per la propria casa e la propria terra: “mi sveglia e poi se ne va, mi vogliono rubare l’anima”. I pensieri di un bambino di periferia tornano a galla ritraendo un Sud che piange e ride mille volte ancora, simile a quello di King Lacreme Lear Napulitane o di Sudd di Leo De Berardinis e Perla Peragallo. Anche qui, di nuovo, qualcosa non è cambiato. Il monito che lancia Rocco Hunt però non è metaforico o sperimentale, ma è verissimo. Riflettendoci un attimo, sputa proprio una verità in faccia mentre balli spensierato sul bridge del brano.
A casa mia
Dove ancora si muore per niente a vent’anni
‘Sti figlie anna capi’
‘Sta guerra adda ferni’
Il mio secondo ripescaggio è invece Fango in paradiso di Francesca Michielin. La scintilla è scattata durante la seconda esibizione, solo allora ho notato come Francesca pronuncia il verso “i tuoi stupidi occhi” e non ho potuto che alzare il sopracciglio destro dall’interesse e concentrarmi sul testo. Il concetto alla base è il topos dei fleurs du mal al contrario ma ciò che più mi ha colpito sono le immagini utilizzate per raccontare – ancora una volta – l’amore che ormai tutti amiamo definire tossico.
La psicologa e arteterapeuta archetipica Valentina Marroni ha tenuto a sottolineare come il Festival lo abbia vinto una canzone sulla “dipendenza affettiva”, “a scapito dell’accettazione della fragilità” – lei dice “maschile” perché fa riferimento a Lucio Corsi, ma io dico “fragilità” e basta perché anche Noemi, ad esempio, l’ha portata sul palco con il suo brano. Però Francesca ha mostrato un coinvolgimento sfrontato cantando la rabbia di un rapporto finito male, con il rimpianto di chi avrebbe voluto fosse “tutt’altro”.
Il lasciarsi perdere serenamente invocato da Noemi qui non c’è, proprio per niente. “Non so se l’avevi considerato che uno dei due sarebbe stato da schifo”, canta Francesca descrivendo l’amore non più come leva di equilibri contrari ma come battaglia all’ultimo sangue all’insegna del massacro, dello spreco di anema e core – per citare la Brancale – di urla, di sentimenti e di “vetri rotti”, gli stessi che anche troviamo anche in BATTITO come “schegge negli occhi”.
Chissà se ti vedrò in giro
Se avrai perso, se avrò vinto
Se c’è fango in Paradiso
#9 – La società del cantautorato
I fantasmi quelli vampirizzati
Quest’anno tanti autori, è vero – Malgioglio non ha risparmiato una battuta durante la seconda serata a questo proposito –, ma anche tanti cantautori. In particolare, la top 5 della finale comprendeva tre cantautori puri su cinque – Cristicchi, Brunori Sas e Lucio Corsi – e altri due autori delle proprie canzoni – Fedez e Olly. Finalmente ci siamo resi conto che anche il rap e il pop sono cantautorato, generi da sempre in bilico nel panorama musicale nazionale e spesso e volentieri privati di giusti e paritari riconoscimenti. Per quanto riguarda gli altri, tutti artisti che, podio o no, hanno ricevuto i massimi riconoscimenti dalla critica.
Tanta Genova quest’anno al Festival di Sanremo, una Genova che ha anche vinto e che vedrà tutta Europa grazie a Federico Olivieri, in arte Olly. Dal backstage social ho anche potuto piacevolmente notare un complice sostegno tra i giovanissimi della nuova scuola cantautoriale: il triangolo “fieramente” genovese Tedua (Cogoleto), Bresh (Bogliasco) e Olly (Foce) è sicuramente interessante proprio perché immortala una scuola ben definita che ha una sua qualità.

Tedua ha portato la sua personale Divina Commedia in un freestyle che l’incisione in studio l’ha vista per fortuna: un tributo al cantautorato stesso, a chi “nel buio della mente” riesce “a splendere”, a costi a volte di mancare di rispetto “a questa musica” scritta “un po’ di getto”, ovvero “il rigetto della personalità” che si ha dentro. Bresh e Olly, invece, in quanto artisti in gara, hanno deciso di portare per la serata dei duetti due brani tra loro molto diversi di De André.
Non posso che menzionare l’esibizione – o le esibizioni – di Crêuza de mä con protagonisti Bresh e Cristiano De André: pelle d’oca, professionalità e un Cristiano – giustamente – infastidito, mentre Bresh si è dimostrato un grande compagno di avventure. Entrambi, come due marinai durante la tempesta fonica, sono sopravvissuti ai venti contrari mentre obbligati a ripetere l’esibizione tre volte – con mia grande felicità – regalandoci un’esibizione che sembrava venire “da ‘n scitu duve a l’ûn-a a se mustra nûa”. Olly invece ha invitato Goran Bregovic e la sua band, portando sul palco forse il lato più rivoluzionario e impegnato di De André.
#10 – La società delle partecipazioni
Cast o canzoni?
Beppe Vessicchio intervistato ieri a Rai Radio 2 ha parlato di “festival dei cantati” più che della canzone, dove “si fa prima il cast e poi si spera che abbiano una canzone valida”. Il Maestro si è anche sbilanciato con l’esempio: “se vuoi Elodie devi sperare che ce l’abbia [la canzone valida], non facciamo mistero di questo”. Addirittura sembra che ad alcuni artisti si sia chiesto di cambiare brano, pur di avere la loro partecipazione sul palco dell’Ariston.
Un Festival così scarno di partecipazioni, senza monologhi, senza ritardi, quasi senza classifiche, senza troppi ospiti, è quindi allora ancora definibile come il frutto del conservatorismo e dell’amichettismo musicale più stantio?
Carlo Conti, che ha dimostrato di essere un uomo di televisione, ha però concluso, secondo me, con charme la classifica della serata finale dove, di fronte a urla di disapprovazione e fischi per la sesta posizione di Giorgia e la settima di Achille Lauro, ha risposto “li lascio gridare ‘Giorgia’ e anche ‘Achille’” perché alla fine, “sarete voi a giudicare nelle prossime settimane”, ovvero quello che il Maestro Vessicchio ha definito “il filtro del tempo”.

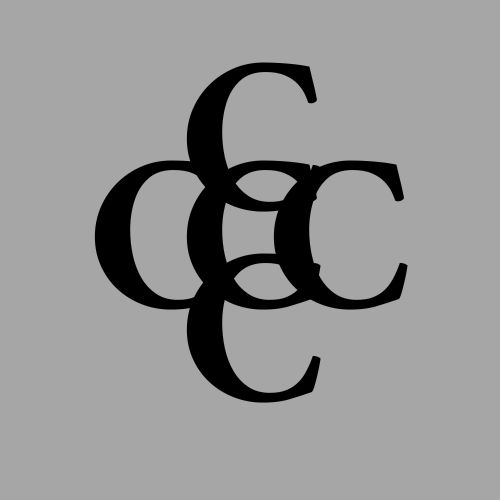

Febbraio 17, 2025 alle 4:07 pm
Complimenti per la recensione, accurata.
Ma soprattutto per la forza e la costanza, di guardare 5 sere/notti Sanremo.
Ammirevole
Febbraio 17, 2025 alle 4:10 pm
Grazie per il tuo feedback!
Pur di divulgare, questo e altro!